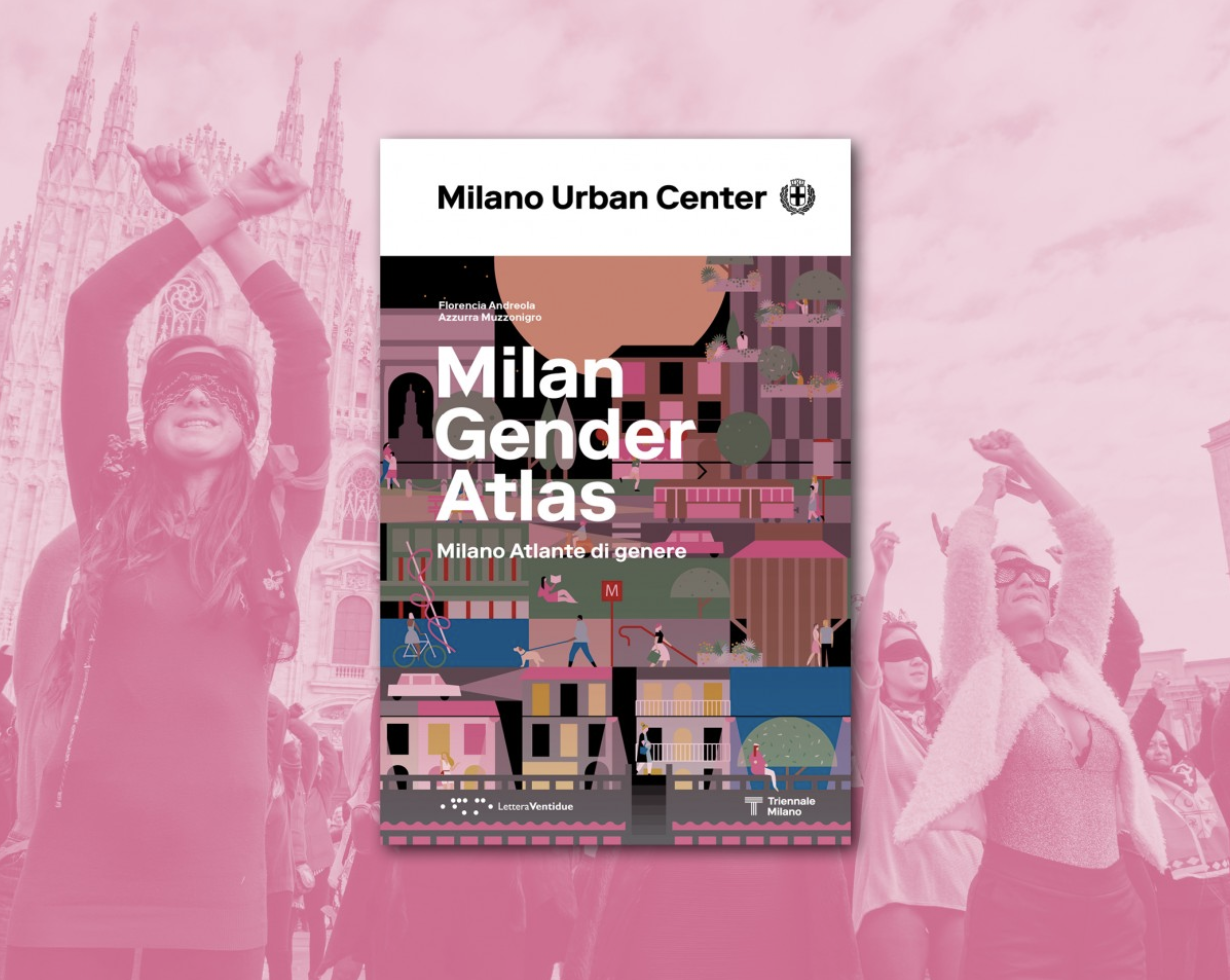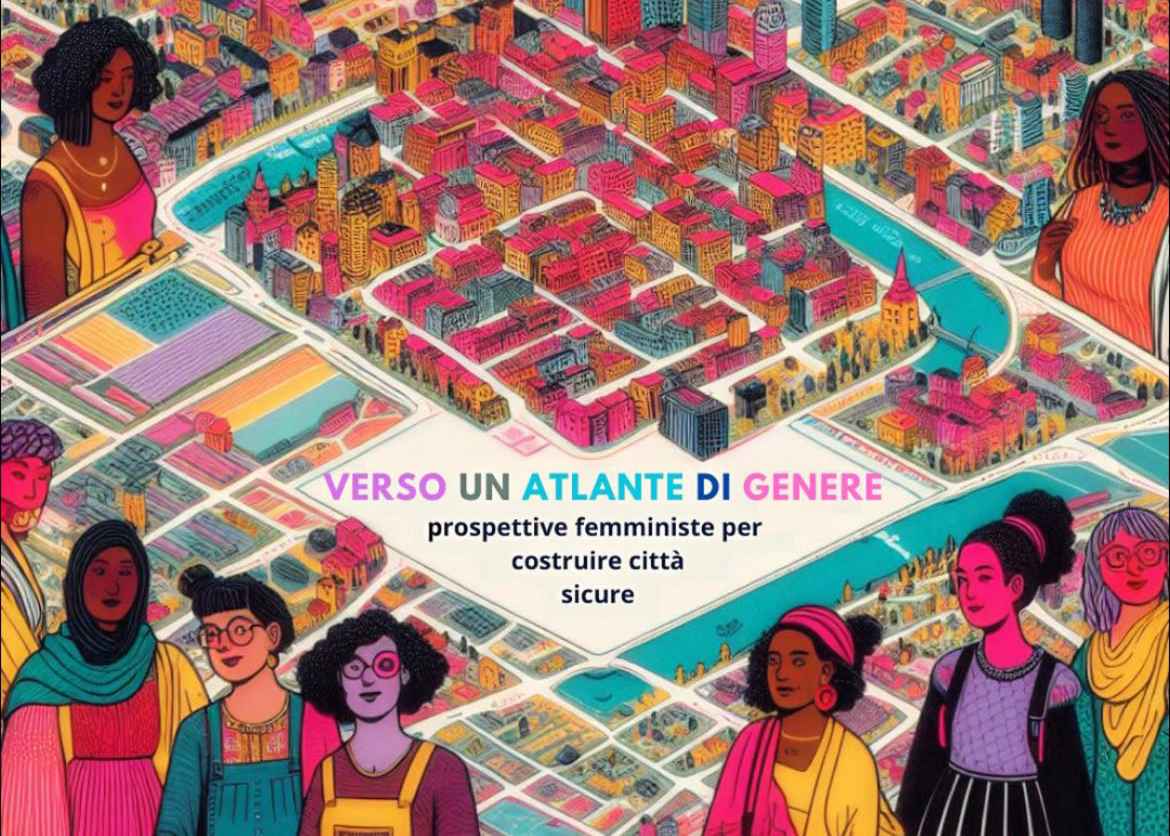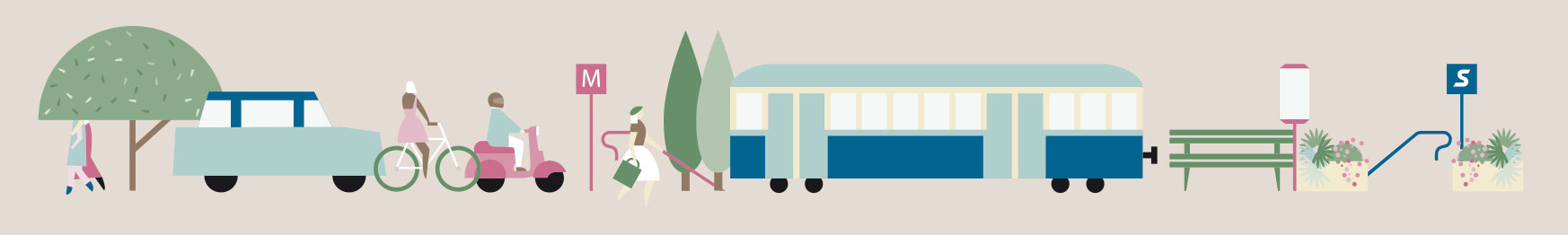
Sex & the City è una lettura di genere degli spazi urbani che persegue il superamento dei dualismi conflittuali tra maschile e femminile, produzione e riproduzione, spazio pubblico e spazio privato.
A partire dalla fine degli anni Sessanta, le teorie femministe hanno portato a pratiche spaziali innovative, suggerendo un nuovo uso sociale dello spazio urbano. Di conseguenza, lo spazio stesso ha assunto nuovi valori e significati. Insieme a ciò, la ridefinizione della soggettività politica delle donne si è costituita, nella sua storia, in luoghi necessariamente separatisti situati al di fuori delle sfere culturali tradizionali e pubbliche, ancora organizzate dagli uomini nella società italiana. Ciò ha significato la creazione di spazi politici contro-culturali e di opposizione, in contrasto con le relazioni di potere esistenti. Il lavoro femminista ha esaminato lo spazio urbano in termini di relazioni spaziali continuamente prodotte e contese all’interno delle città. Lo spazio urbano, inteso essenzialmente come prodotto sociale, riguarda una serie di relazioni che sono create da forze di produzione, pratiche sociali, tecnologie e prodotti della conoscenza diversi, come anche strutture e istituzioni sociali. Varie indagini non solo hanno dimostrato un uso differenziato dello spazio pubblico da parte di uomini e donne, ma confermano inoltre che queste ultime variano i loro percorsi quotidiani, i luoghi che attraversano e l’orario di molte delle loro attività, per paura e per percezione di insicurezza. Le loro percezioni sono legate alle esperienze quotidiane e alle interazioni sociali che si oppongono al valore di “scambio” normalmente riferito al contesto urbano, alla rigida funzionalità dei loro usi e alla materialità statica e immutabile delle rappresentazioni dominanti ed escludenti.
Una pianificazione urbana attenta anche a questi fattori e sensibile al carattere caotico, dinamico e complesso che racchiude la realtà urbana stessa, non può progettare città irrigidite da concezioni tecniche ideali, razionali e chiuse, ma deve necessariamente essere aperta alla collaborazione, alla negoziazione e partecipazione dei diversi attori che abitano spazi pubblici e privati. Ridisegnare le città in una prospettiva di genere significa «concepire lo spazio urbano in modo flessibile, con la capacità di rispondere ai bisogni, ai desideri e alle rappresentazioni socio-spaziali della diversità dei soggetti, incorporando i diversi modi di vivere e di rendere effettivo il diritto alla città» (Tello, 2009:288).
Sex & the City sviluppa ricerca in forma indipendente. Le pubblicazioni realizzate fino a qui sono disponibili a questo link.
Alcuni temi trattati dalle ricerche di Sex & the City si sono tradotti in un PODCAST divulgativo in quattro puntate, realizzato in collaborazione con Radio24. Le puntate sono disponibili qui: